Preserviamo il nostro udito; diventare sordi non ci trasformerà nei nuovi Beethoven
- Alvise Cappello
- Jul 28, 2016
- 3 min read

Sia i musicisti che gli ascoltatori di musica riconoscono (e come non dargli torto) nell’ orecchio e nell’ apparato ad esso collegato il principale strumento fondamentale per la fruizione musicale. Ma se dunque, lasciando da parte casi singolari di deficit dell’ udito, l’ orecchio è lo strumento di lavoro principale di noi musicisti, quanto effettivamente ci impegniamo a salvaguardare tale organo?
Iniziamo con il definire, in maniera molto semplicistica, quale siano le grandezze di misura utilizzate in àmbito acustico e quale sia il meccanismo biologico che ci permette di tradurre la vibrazione fisica in una percezione neurosensoriale.
Parlando di misurazioni fisiche, due sono le grandezze più note utilizzate in acustica e servono l’una a definire la pressione sonora (decibel) e l’altra a misurare la frequenza d’onda (Hertz). Ciò che differenzia nettamente queste due grandezze è che i valori matematici del decibel, in quanto di derivazione logaritmica del Bel, sono esprimibili nella stessa unità di misura e quindi il loro rapporto è definibile come adimensionale.
In sostanza, la grandezza espressa dai decibel non è una vera e propria grandezza fisica, ma percettiva, a differenza dell’ Hertz che invece descrive fisicamente la frequenza di oscillazione dell’ onda sonora (misurata al secondo).
Questa differenza ci torna utile nel momento in cui andiamo a cercare di capire come il nostro apparato uditivo funzioni:
cercando di utilizzare terminologie semplici, il suono genera movimento dell’ aria e
tale pressione sonora (espressa in dB) viene captata dai nostri padiglioni auricolari e successivamente incanalata nel condotto uditivo fino ad arrivare alla membrana timpanica, che risponde attivamente a queste vibrazioni.

Tralasciando ulteriori specificazioni anatomiche, la vibrazione del timpano viene tradotta dal movimento di piccolissimi ossicini che battono all’ interno di una “sacca” di liquido (chiamata chiocciola). Il movimento di questo liquido stimola i filamenti sensitivi delle cellule uditive che traducono questa vibrazione in impulsi bio-elettrici, permettendo così il loro passaggio nel sistema nervoso.
Ho voluto innanzitutto darvi queste informazioni tecniche in quanto potrete meglio capire come funziona il sistema uditivo e di conseguenza intuire quale sia il vero problema che può causare la perdita di udito nel mondo della musica.
Tendenzialmente, infatti, si da per scontato che sia il volume elevato a creare danni all’ udito, ma non ci si domanda quasi mai in che cosa effettivamente consista questo eccessivo quantitativo di dB all’ interno del nostro orecchio, sottovalutando spesso quanto in realtà basti anche una esposizione a volume moderatamente “normale” per diverse ore perché a lungo termine possano manifestarsi deficit uditivi.
Se infatti teniamo conto di tutti gli aspetti anatomici sopra definiti, ci rendiamo conto che il nostro apparato uditivo è forse il sistema percettivo con gli “organi” di senso più fragili e piccoli di tutto il resto del corpo umano ( si parla di membrane dalle dimensioni millimetriche, mentre se già pensiamo alla vista, al tatto o al gusto, parliamo di organi di senso grandi almeno il doppio rispetto a quelli uditivi); questo si traduce con una maggiore sensibilità al trascorrere del tempo ed agli stimoli violenti.
Arriviamo ai dati più interessanti.
Se diamo un occhio ai livelli di guardia con relative tempistiche di esposizione pubblicati dall’OSHA, Occupational Safety and Health Administration americana, vediamo come già ad 85 dB venga riconosciuta la soglia di pericolosità per il livello di rumore. a 95 dB il rischio di danni è maggiore per esposizioni superiori a 4 ore e tale rischio è inversamente proporzionale all’ aumento dei dB (concludendosi ai 160 dB dove viene riconosciuto il danno fisico immediato).

In termini musicali, dunque, già l’ ascolto di 4 ore di musica amplificata live, può
comportare danni all’ udito, mentre il solo suono di un pianoforte (con dinamica
forte) rientra nei livelli di pericolosità. Per non parlare di ambienti come la sala prove, dove si raggiungono tranquillamente picchi al di sopra dei 120 dB per tempistiche abbastanza prolungate.
Con questi dati verrebbe spontaneo pensare che un musicista sia destinato inevitabilmente a perdere l’ udito.
Seppure questa pessimistica osservazione possa essere in parte vera (ogni lavoro che richiede uno sforzo fisico, seppur eseguito in sicurezza, a lungo termine comporta maggiori possibilità di problemi fisici), ci sono delle soluzioni a questo flagello e quella a mio parere più efficace è la soluzione proposta dalla Alpine, che ha commercializzato dei tappi per orecchie specifici per musicisti.
I MusicSafe, infatti, sono dei tappi auricolari studiati appositamente per eliminare il range di frequenza più sensibile al decadimento percettivo.

Visto il prezzo decisamente basso (su Amazon si trovano per poco meno di 20€) ed il loro possibile riutilizzo, li ritengo gli strumenti di protezione uditiva più utili rispetto a dei semplici tappi di spugna o silicone monouso.
Voi avete mai pensato alla prevenzione del vostro udito?
Fonti:
http://www.ziomusic.it/2013/10/17/il-musicista-e-la-sicurezza-delludito/
http://www.orlteam.it/orl/13/ipoacusia-disturbi-udito.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Decibel









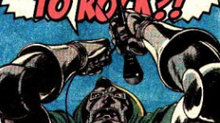





































Comments